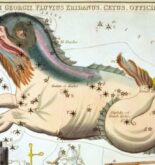Nel pomeriggio di giovedì 17 aprile 2025, presso l’Università degli Studi di Milano, si è tenuta, nell’ambito del corso di Storia Contemporanea del professor Mauro Elli, una conferenza del professor Francesco Cassata, ordinario di Storia contemporanea all’Università di Genova. L’incontro, dal titolo Asilomar 1975–2025: una prospettiva europea, ha posto al centro dell’attenzione la storia della biologia molecolare e, in particolare, il ruolo cruciale e controverso svolto dalla conferenza di Asilomar, svoltasi nella località californiana dal 24 al 27 febbraio 1975.
La conferenza di Asilomar si focalizzò sul tema delle molecole di DNA ricombinante, una tecnologia all’epoca emergente, strettamente legata allo sviluppo dell’ingegneria genetica. Tale approccio apparve sin da subito promettente, poiché permetteva di isolare materiale genetico da virus e combinarlo con quello batterico, trasformando questi ultimi in vere e proprie biofabbriche capaci di produrre specifiche proteine. Queste tecniche furono da subito applicate alla produzione di vaccini, come quello contro l’epatite B, e di proteine fondamentali come l’insulina.
Nel contesto dell’euforia scientifica del secondo dopoguerra, la rapida avanzata di questo settore suscitò grandi entusiasmi, ma allo stesso tempo generò timori e interrogativi etici circa i rischi potenziali. Fu proprio questo senso d’urgenza a spingere Paul Berg, biochimico statunitense e futuro premio Nobel, a pubblicare nel luglio del 1974 una lettera su “Science” e “Nature”, nella quale invitava la comunità scientifica a sospendere momentaneamente le ricerche nel campo del DNA ricombinante, al fine di avviare una riflessione collettiva sulle possibili conseguenze di un utilizzo non regolamentato di tali tecnologie.
Fin dall’inizio, la conferenza di Asilomar fu percepita come un evento di rilevanza storica. La raccolta di fonti e testimonianze fu immediata, alimentata dalla consapevolezza del suo carattere eccezionale. Proprio questo senso di urgenza contribuì a generare una vera e propria dimensione memorialistica attorno all’incontro, che si trasformò nel tempo in un mito: il cosiddetto “spirito di Asilomar”.
Tuttavia, questa narrazione idealizzata ha nel tempo prodotto una sorta di oscuramento delle numerose contraddizioni che l’evento portava con sé. Una prima tensione emerse nel rapporto tra la dimensione scientifica e quella etica del dibattito. Un altro nodo problematico fu il fatto che la discussione sui rischi si basava su scenari ipotetici, non supportati da dati sperimentali concreti. Inoltre, la conferenza non si limitò a valutare i pericoli della nuova tecnologia, ma tentò anche di definire una vera e propria science policy, ovvero una politica di prevenzione del rischio. Va infine sottolineato un altro elemento ambivalente: Asilomar fu da un lato rivolto agli addetti ai lavori, ma allo stesso tempo al simposio vi presero parte sedici giornalisti, a testimonianza del suo carattere anche mediatico.
Non sorprende, dunque, che fin da subito emerse un’interpretazione ambivalente dell’evento, con una dicotomia tra chi considerava Asilomar una guida e chi la percepiva come un incubo. Le critiche si articolarono lungo due principali direttrici: da una parte, vi erano coloro che giudicavano la conferenza del 1975 un episodio assurdo e irrazionale, accusandola di aver avuto un impatto politico sproporzionato e di essere stata eccessivamente permeata da una retorica allarmista. A sostenere questa visione fu anche James Watson, uno dei padri della scoperta della struttura del DNA, che giudicò l’incontro come un errore infantile della comunità scientifica, colpevole di aver evocato mostri immaginari e condotto a regolamentazioni e limitazioni eccessive.
Dall’altra parte, vi era chi non ne metteva in dubbio la razionalità, ma ne criticava l’impostazione elitaria e tecnocratica. A sposare questa posizione fu spesso l’area della sinistra radicale, che talvolta rievocava, nei confronti dell’ingegneria genetica, le critiche alle derive eugenetiche sostenute dal regime nazista.
Nel suo intervento, il professor Cassata ha illustrato l’approccio di ricerca da lui adottato per riesaminare la conferenza a cinquant’anni di distanza, con l’obiettivo di proporre una lettura che si svincoli dalla tradizionale prospettiva statunitense, per abbracciare una visione più internazionale, con particolare attenzione al ruolo dell’Europa.
La partecipazione europea ad Asilomar avvenne attraverso l’EMBO (European Molecular Biology Organization), un ente scientifico che riceveva fondi da parte degli stati e che si adoperava per incentivare gli investimenti pubblici nella biologia molecolare. In quest’ottica, Asilomar venne utilizzata come strumento retorico e politico per persuadere i governi europei a sostenere finanziariamente la ricerca, in risposta al timore che la biologia molecolare si trasformasse in un’esclusiva statunitense.
L’impatto pratico dell’incontro californiano in Europa fu rilevante: le linee guida elaborate durante la conferenza furono recepite e utilizzate nei corsi di formazione e negli esperimenti scientifici volti alla valutazione del rischio. In particolare, esse influenzarono la progettazione del laboratorio europeo di biologia molecolare, inaugurato nel 1977, che doveva essere una struttura ad alto contenimento. Proprio in questa contraddizione si rese evidente la complessità della posizione della comunità scientifica: da un lato si chiedevano regolamentazioni severe per contenere i possibili pericoli delle nuove biotecnologie, e dall’altro si costruivano infrastrutture per condurre esperimenti ad alto rischio.
Lo “spirito di Asilomar” continua ancora oggi a esercitare un’influenza notevole, sia a livello scientifico che immaginario, sollevando l’annoso problema tra storia e memoria. I recenti sviluppi nel campo dell’ingegneria genetica, come la tecnologia CRISPR-Cas9, hanno riportato alla luce il mito di Asilomar, così come i più attuali dibattiti sull’intelligenza artificiale fanno riecheggiare sui fogli di stampa interrogativi simili, tra promesse utopiche e timori distopici per il futuro.
Davide Lorenzo Pezzali