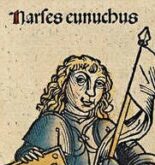La Svizzera occupa all’interno degli studi sulla Seconda guerra mondiale uno spazio spesso marginale, relegata ad attore neutrale e quasi ininfluente delle vicende che hanno infiammato lo scenario europeo e mondiale. A maggior ragione non si ha spesso conoscenza dei protagonisti confederati che hanno mantenuto la nazione lontana dal conflitto. Proprio al più influente e celebrato di questi personaggi è dedicata la tesi. Henri Guisan fu il comandante in capo delle forze armate svizzere durante la Seconda guerra mondiale, anni in cui si appropriò dell’appellativo di “difensore a oltranza delle forze morali”. A lui si deve la decisione di istituire il “ridotto nazionale” come dispositivo difensivo, un efficiente sistema militare che prevedeva il dispiegamento di gran parte delle truppe in un perimetro circoscritto all’interno delle Alpi svizzere imperniato sulle fortificazioni di Saint Maurice, Sargans e del Gottardo. Il resto delle divisioni rimaneva all’esterno, a difesa delle frontiere e delle postazioni sensibili, con l’appoggio ausiliario della popolazione e delle guardie locali, istituite da Guisan il 7 maggio 1940. Strade, ponti, valichi erano minati e pronti a essere fatti saltare in caso di necessità. Tutto il territorio svizzero, tra le Alpi e il Giura, dal Lemano al Reno, era sorvegliato e munito in ogni postazione. I rilievi del Giura, i fortini del Reno e gli appostamenti dell’altipiano costituivano le murate esterne.
Guisan ha assunto i tratti dell’eroe tipicamente svizzero, è diventato parte integrante della narrazione della storia nazionale della Confederazione elvetica: nei manuali scolastici ancora oggi è descritto come il «difensore dello spirito di resistenza», l’attore fondamentale per il mantenimento dei tratti distintivi della nazione di democrazia, neutralità, indipendenza.
Scopo della tesi è stato quello di ricercare la presenza di questa figura all’interno del discorso pubblico svizzero: lo si è fatto attraverso i quotidiani, le riviste, i manuali scolastici, verificando tempi e modalità attraverso cui il nome di Guisan è stato associato allo spirito di resistenza dell’esercito e della popolazione. La consultazione di una ricca bibliografia in lingua francese e tedesca, di quotidiani e riviste militari svizzeri ha permesso di ampliare lo sguardo, anche grazie all’utilizzo dei fondi dell’Archivio federale, la Geschichte Bibliothek dell’Historisches Institut dell’Università di Berna e il Centro di ricerca e relativa biblioteca nella Guisanplatz.
L’accerchiamento del territorio svizzero dopo la resa francese nel giugno 1940 a seguito dell’invasione nazista contribuì a creare un clima di forte preoccupazione tra la popolazione e le truppe. Il discorso radiofonico del Presidente della Confederazione Marcel Pilet Golaz, pronunciato il 25 giugno 1940, sembrava suggerire la volontà di allineare il Paese al nuovo ordine che si stava creando in Europa ad opera della Germania nazista. Esattamente un mese dopo, il 25 luglio, venne invece annunciata l’adozione del meccanismo del ridotto, in occasione del celebre Rapporto sul praticello del Grütli, alla presenza di circa 500 generali. Da un embrionale dispositivo di difesa militare dei soli confini nazionali, che avrebbe comportato la sorveglianza di 1900 chilometri lungo la frontiera, si passava all’adozione del ridotto: con esso, una buona fetta dell’esercito veniva concentrata all’interno delle Alpi, ritenute a livello difensivo la zona più favorevole per combattere. Il suo scopo consisteva nel difendere una determinata porzione di territorio – le Alpi svizzere con il San Gottardo come punto centrale –, che costituiva l’obiettivo maggiormente ambito dai tedeschi per la creazione di un collegamento diretto tra Roma e Berlino.
Alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, una commissione indipendente di esperti, presieduta da Jean-François Bergier, ha messo sotto la lente d’ingrandimento l’azione di Guisan, nel contesto di un riesame dell’operato della Svizzera durante la Seconda guerra mondiale. È stata così rivista in termini meno oleografici la narrazione storiografica della neutralità e della preparazione di un’adeguata resistenza armata a un’eventuale invasione della Wehrmacht. Si è parlato di connivenza economica della Confederazione con il Reich, di una politica troppo restrittiva nei confronti dei richiedenti asilo e dei rifugiati e dei consistenti fondi in giacenza presso le banche nazionali appartenenti alle vittime delle persecuzioni naziste. Lo stesso Guisan è stato criticato per essere venuto meno ai consolidati principi di neutralità, avendo preso contatto, a conflitto ancora non iniziato, con i vertici militari francesi, in vista di un accordo in caso di invasione tedesca.
Questa revisione storiografica non sembra tuttavia aver scalfito la presenza di Guisan nel discorso pubblico, come testimoniano le celebrazioni studiate nell’ultimo capitolo della tesi. In particolare, sono stati esaminati alcuni anniversari importanti, quelli della nascita, della morte, e del celebre rapporto sul praticello del Grütli. Salvo brevi periodi in cui la sua azione è passata un po’ sotto silenzio, soprattutto negli anni Settanta, non si registrano voci fuori dal coro su quotidiani, siti internet e riviste militari. La sua figura è stata spesso richiamata in varie occasioni per evocare lo spirito di unione, di neutralità̀ o di sacrificio del paese contro il disorientamento politico e morale. Nel 2019, ad esempio, è stato celebrato l’80° anniversario della mobilitazione attiva del 1939, di cui Guisan è stato indiscusso protagonista. In occasione del 30° anniversario della mobilitazione attiva gli furono dedicati un busto ad Avenches e un francobollo, per il 50° una moneta con il suo volto. Il monumento per eccellenza è sicuramente la statua equestre inaugurata nel 1967 a Ouchy, nel canton Vaud.
Anche i funerali del generale, celebrati il 12 aprile 1960, sono un osservatorio interessante per quantificare il grado di apprezzamento e la popolarità di cui ancora godeva a quindici anni dalla fine del conflitto. Unanime fu la partecipazione delle autorità politiche e della popolazione, con una presenza alla cerimonia stimata intorno alle 300.000 persone.
Un’altra conferma del fatto che Guisan è entrato a pieno titolo nella memoria pubblica del Paese è data dal richiamo puntuale del suo nome in occasione della festa nazionale del 1° agosto: la giornata ricorda la nascita della Confederazione svizzera nel 1291, il più antico atto costituzionale attraverso il quale i cantoni primitivi – i Waldstäatten – di Uri, Svitto e Nidvaldo si promisero aiuto reciproco contro chiunque avesse esercitato contro di loro violenza o torto.