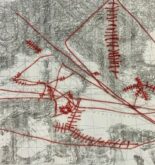Il 4 aprile scorso, nell’ambito del corso di “Storia delle monete medievali e moderne” del Dipartimento di Studi Storici “Federico Chabod”, Vittoria Camelliti dell’Università degli Studi di Udine ha tenuto un seminario sulla comunicazione politica attraverso i segni identificativi delle città nel basso medioevo.
Nella parte introduttiva della lezione, Camelliti ha sottolineato come parlare di segni dell’identità civica vuol dire riferirsi al patrimonio di immagini, simboli e parole usati nei secoli per rappresentare la città ed esprimere la propria identità. Ma i segni identitari, che venivano trasmessi dalle monete, sigilli e vessilli, mutano nel tempo e permettono così di comprendere le profonde trasformazioni occorse da un punto di vista identitario e sociale.
Le monete rappresentano il primo prodotto di massa della storia e per questo ben si prestavano a veicolare messaggi identitari destinati ai cittadini o ai poteri politici concorrenti, attraverso le loro immagini e iscrizioni.
Parimenti, anche i sigilli adempievano alle medesime funzioni, ma in virtù della minor durabilità del materiale su cui erano impressi, sono giunti a noi in numero molto minore.
I vessilli e gli scudi invece rappresentano il supporto naturale degli emblemi araldici ed erano pensati per essere esposti nei più importanti luoghi pubblici, ma anche di questi si sono conservati pochi esemplari, sia per la loro scarsa durabilità materiale, sia perché essendo prodotto di un potere politico, la loro sopravvivenza era legata a quella dell’autorità che li aveva creati. Per questi motivi, la maggior parte delle informazioni che si possono ricavare sui vessilli è estraibile soprattutto da alcune rappresentazioni, come nel caso della Misericordia Domini a Firenze: qui è raffigurata la città, sulla cui porta campeggiano alcuni stendardi che consentono di datare l’immagine ad una fase successiva alla dominazione angioina, data l’assenza di quel vessillo, che invece compare nel Libro del Biadaiolo.
L’araldica si può esprimere anche in modalità diverse: ad esempio la Personificazione del Buon Governo del Lorenzetti è vestita con un abito bianco e nero (i colori della città) e tiene in mano un grande sigillo: in questo caso la città è resa tramite alcuni degli elementi dalla maggior valenza identitaria.
I vessilli erano impiegati anche in contesti differenti, per esempio nell’ambito di investiture politiche, come mostra l’Arca di Cangrande in cui Enrico VII concede il dominio su Verona a Cangrande attraverso il passaggio del vessillo imperiale. In altre cronache invece i vessilli hanno lo scopo di permettere l’identificazione di una città, come nel Codex Astensis che mostra il Castro Rupis su cui si stagliano due vessilli astigiani, insieme a quello visconteo che invece mostra quale potere si esprimesse su di esso in quel momento.
I vessilli erano presenti anche sui carrocci come ben si osserva nella Nuova Cronica del Villani, in cui sarebbe rappresentato il carroccio milanese: uno strumento dal grande valore identitario su cui si stratificano una serie di simboli, a partire dalle immagini divine come il Cristo crocifisso o il patrono locale. In questo caso l’utilizzo del condizionale è necessario dato che il carroccio è mostrato in occasione dell’ingresso di Federico II a Cremona dopo la vittoria nella battaglia di Cortenuova, ma la raffigurazione appare piuttosto lontana dall’essere fedele, partendo dai colori invertiti nel vessillo cittadino (in questo caso una croce bianca in campo rosso), quasi come se il miniatore avesse frainteso il testo, rappresentando il vessillo cremonese.
In ogni caso i carrocci permettono di osservare la persistenza di questi simboli nell’identificazione di una città: in occasione del palio di Legnano sfila tutt’oggi un carroccio milanese, che si propone di essere fedele all’originale, mostrando una riproduzione della Croce di Ariberto (della chiesa di S. Dionigi), presunto “inventore” di tale oggetto; come spesso accade però, si tratta di un’invenzione ottocentesca non corroborata da alcuna fonte, e che anzi appare inverosimile alla luce della preziosità e del peso della croce.
Esistono anche altri simboli che tutt’oggi hanno un valore ufficiale, come lo stemma, il gonfalone, la bandiera e i sigilli di Milano. In particolare, nel gonfalone del 1972, copia di quello del 1923, compaiono tutti i segni identitari: S. Ambrogio con lo staffile, in riferimento alla sua lotta contro gli eretici ariani, accanto ai SS. Gervasio e Protasio; è poi presente lo stemma di Milano con i simboli delle sei porte cittadine, rimasti invariati rispetto a quelli tramandati da Bonvesin della Riva, se non per porta ticinese; infine, si può osservare l’animale totemico di Milano, ossia la scrofa semilanuta.
Il gonfalone del 1923 fu prodotto per sostituire quello del 1566, in cui apparivano i medesimi elementi ad eccezione dell’animale, probabilmente perché non era percepito come segno identitario della città, come sarà poi grazie ad un suo recupero. È corretto proprio parlare di recupero e non di invenzione soprattutto guardando ad una tradizione che ne fa uno dei segni più antichi della città, a partire dalle Etimologie di Isidoro di Siviglia e toccante l’anonimo Libellus de situ civitatis Mediolani. Esso appare poi nelle miniature della Chronica Galvaniensis, in cui sono narrate le diverse leggende sull’origine del nome di Milano; ma forse la più nota rappresentazione dell’animale è all’esterno del Palazzo della Ragione, anche se permane incertezza circa la sua datazione. In ogni caso, l’idea che questo fosse un simbolo dell’identità civica milanese già nel XIII secolo è corroborata da uno studio di Marta Luigina Mangini su un registro dell’amministrazione comunale di porta cumana in cui compare lo stemma della porta assieme alla scrofa.
A proposito del palazzo della Ragione, sono del medesimo periodo quegli affreschi frammentari in cui compaiono gli stemmi delle porte cittadine nelle mani di alcuni uomini in arme; sempre questi poi sono associabili alla Loggia degli Osii su cui compaiono gli scudi delle varie porte, che furono però oggetto di un importante rifacimento nel XX secolo.
La loggia dell’edificio in facciata presenta anche cinque arcate, le tre centrali delle quali ospitano alcune copie ottocentesche di statue originali (ora in collezioni private). Si tratta di figure sacre, la cui presenza sulla facciata di un palazzo pubblico non è casuale dato che erano anch’esse rappresentative dell’identità civica, partendo dal santo patrono: a Milano si tratta di Ambrogio e la sua statua è evidentemente mutila, ma la postura lascia supporre che tenesse il pastorale e lo staffile.
L’iconografia di s. Ambrogio con lo staffile, o con un oggetto simile, probabilmente risale ad un rilievo scolpito per porta romana nel 1171 in cui il santo scaccia gli ariani; successivamente e fino alla prima metà del XIV secolo il patrono milanese perde questa caratterizzazione, comparendo invece benedicente, come mostrano chiaramente le monete: dalla sua prima apparizione nelle monete del Comune nel 1254/56, la sua iconografia rimase invariata anche sotto i Visconti. Una svolta avvenne nel 1354 con le monete di Bernabò quando il santo appare con lo staffile in riferimento alla sua miracolosa apparizione nella battaglia di Parabiago per scacciare i nemici, secondo la leggenda tramandata da Galvano Fiamma.
Alla fine degli anni Trenta del XIV secolo tale iconografia divenne sempre più usuale, come nel caso dell’arca di san Pietro martire, realizzata da Giovanni Baluduccio dal 1337, che però mostra Ambrogio con lo staffile “a riposo”, non brandito contro i nemici. Tale scelta stilistica è antecedente alla leggenda di Parabiago, e dunque indipendente da questa, che anzi potrebbe aver ispirato mediante il recupero di un modello più antico.
Negli stessi anni la bottega del Balduccio su commissione di Azzone Visconti produsse tre statue ambrosiane, in cui il patrono compare assieme ad altri santi nell’atto di dedica alla Madonna; questi gruppi scultorei erano parte di un progetto più ampio che venne interrotto con l’improvvisa morte di Azzone, per essere poi ripreso (e affidato al maestro anonimo della scultura di Viboldone) con la realizzazione di altri tre gruppi in cui Ambrogio brandisce un oggetto perduto, ma che certamente era uno staffile. Questo grande progetto ambiva a inscenare sulle porte urbiche una dedica della città alla Madonna tramite il patrono, attorniato dai santi titolari delle diverse chiese presenti nel sestiere, come per schierare la totalità dei santi più cari a Milano nella difesa della città. Ciò poteva appoggiarsi a modelli ben consolidati, a partire da un affresco (parzialmente sopravvissuto) di Giotto in cui è rappresentata la dedizione alla Madonna da parte di Firenze, che è resa tramite s. Reparata al fianco del Comune e di sei figure, le quali tengono in mano i simboli dei sestieri cittadini. Proprio questa idea di rappresentare la dedizione tramite un patrono e le differenti parti costituenti della città è quella che ritorna nel grande progetto di comunicazione politica del Balducci, forse ispirata dallo stesso Giotto, presente alla corte di Azzone in quel periodo.
Un altro importante simbolo della Milano viscontea è la biscia, seppur ne siano sopravvissute poche raffigurazioni dell’epoca di Azzone, mentre sono più frequenti quelle successive. Ben conservata invece è la tomba di Azzone scolpita dal Balducci, il cui programma decorativo è un’eccezionale rappresentazione allegorica del potere: mostra la sottomissione delle diverse città a Milano, nuovamente attraverso l’utilizzo dei santi; quello milanese è affiancato da due figure identificate come il Comune, reggente assieme ad Ambrogio il vessillo di Milano, e la Signoria, che teneva un oggetto perduto ma certamente rappresentativo del potere signorile. Le dieci città che convergono verso il centro sono personificate da uomini con vesti e scudi decorati con i simboli civici, alle cui spalle stanno i rispettivi santi patroni, impiegando così contemporaneamente due piani comunicativi differenti: umano e divino.
Nel codice Latin 6467 alla biblioteca nazionale di Francia, si conserva una simile rappresentazione delle diverse città sottomesse a Milano, rappresentata alla sommità del codice: in particolare questa è sormontata da una corona d’oro e affiancata da due vipere viscontee, dalla forte valenza politica. Simile è l’immagine presente nel Libro dei Censi di Siena del 1400, quando la città era nelle mani viscontee, in cui la “S”miniatadi Sienaè sormontata dalla biscia viscontea su cui campeggia l’aquila imperiale, a legittimazione del potere di questa importante famiglia signorile.

Per concludere, si può evidenziare come da questo seminario sia emersa l’importanza di ampliare gli studi a tutta quella serie di strumenti di comunicazione a disposizione dei poteri politici, che rappresentavano un canale alternativo o complementare per esprimere il proprio potere o la propria identità.
Matteo Galli e Davide Volpi