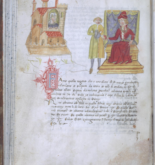Stefano Vianelli, Anna di Savoia imperatrice e reggente. Ruoli e strategie di potere femminile attraverso le crisi del XIV secolo a Bisanzio, Università degli studi di Milano e Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Dottorato di ricerca in Studi Storici (XXXVI ciclo), tutors prof.sse Laura Mecella e Sophie Métivier
L’elaborato si propone di indagare con un taglio prevalentemente storico-politico la figura di un’importante imperatrice bizantina del XIV secolo, nota alla storiografia come Anna di Savoia. Alla morte del marito Andronico III Paleologo, nel giugno 1341, Anna fu infatti reggente per conto del figlio Giovanni V, allora bambino, ricoprendo tale ruolo per quasi sei anni fino al febbraio del 1347. La Reggenza dell’imperatrice coincise con una lunga guerra civile che oppose un fronte legittimista, schierato a sostegno della dinastia paleologa, e una fazione favorevole invece all’ex megas domestikos (comandante in capo dell’esercito), Giovanni Cantacuzeno. La profonda crisi che investì la struttura politica e sociale dell’impero – e che si configura come una svolta maggiore nella sua storia tardiva – si manifestò anche sul piano economico, religioso, militare e ideologico: il discorso sul potere imperiale di Anna di Savoia diventa pertanto un prisma per l’indagine di uno snodo storico di notevole interesse, con implicazioni relative anche allo stesso pensiero politico bizantino.
La tesi si apre con un’introduzione storiografica e metodologica, seguita da tre capitoli, ognuno dei quali dedicato ad un aspetto della ricerca, seguiti a loro volta da conclusione complessiva. Dopo una presentazione critica delle fonti (I), l’indagine si sviluppa lungo due assi principali: da un lato, i fondamenti e i limiti del potere di Anna in quanto donna e imperatrice (II) e, dall’altro, l’esercizio di tale potere (III).
Il secondo capitolo procede a un riesame della titolatura di Anna di Savoia alla luce delle diverse sfumature offerte dalla terminologia ufficiale (Augusta, basilis, despoina). In seguito, è studiato il ruolo svolto da Anna durante il regno del marito Andronico III (1328-1341), che ne fece un elemento essenziale della sua politica di successione investendovi tutte le sue risorse simboliche e politiche. Si ricostruisce specialmente il periodo di trapasso tra la fine del regno di Andronico III e la costituzione della Reggenza per conto del figlio Giovanni V nel giugno 1341. Il capitolo si conclude con una presentazione dei paralleli contemporanei di reggenza femminile nell’area bizantina in senso lato (Epiro e a Trebisonda), nonché del precedente di minorità imperiale più citato nelle nostre fonti, ovvero quello di Giovanni IV Lascaris, che fu estromesso dal potere e accecato da Michele VIII nel 1261.
Nel terzo e più esteso capitolo, sull’esercizio del potere, vengono studiati in particolare la creazione e la promozione dell’immagine imperiale di Anna, la sua cerchia e i meccanismi della sua gestione del potere, dove la repressione dell’opposizione interna riveste un interesse particolare. I tre aspetti appaiono collegati, in quanto è attraverso il monopolio degli spazi di manifestazione dell’autorità imperiale che Anna di Savoia e suo figlio promossero le proprie figure di unici detentori della legittimità, ed è l’uso efficace e soprattutto esclusivo di tale legittimità che determinò non solo la sopravvivenza ma anche l’efficacia politica della reggente. L’analisi prosopografica della cerchia di Anna ha permesso di concludere che le alleanze che questa strinse con i membri del proprio entourage si fondano da un lato sulla capacità legittimante della sovrana e, dall’altro, sulla dipendenza da parte dei suoi dignitari nei confronti di tale avallo politico. Sono ricostruiti con particolare attenzione i profili dei tre personaggi più influenti della Reggenza, ossia il patriarca Giovanni Caleca, il megas doux Alessio Apocauco e il mesazon Giovanni Gabalas.
Nell’esercizio del potere di Anna, un ruolo decisivo è giocato dalla repressione del dissenso, che fu esercitata con efficacia nei confronti di ogni contestazione dell’esclusività imperiale della reggente e di suo figlio: a farne le spese, fu innanzitutto Giovanni Cantacuzeno, al quale si aggiunsero i suoi fiancheggiatori veri o presunti, tanto nell’ambito civile che in quello religioso. Tra essi, il caso più eclatante è la deposizione del patriarca Giovanni Caleca nel febbraio 1347, che è studiata nel dettaglio e fatta oggetto di una ricostruzione cronologica e politica.
Le conclusioni riprendono il concetto di mos imperiale tardobizantino per contestualizzare il tentativo di Anna di accreditarsi come rappresentante della legittimità imperiale: malgrado la temporanea sconfitta militare del 1347, la costruzione politica elaborata da Anna si mostra solida e durevole, in grado di trovare risposte efficaci alle molteplici e profonde crisi del suo regno.
This study, aims to investigate, from a mainly political history perspective, the figure of an important 14th-century Byzantine empress, known to historians as Anna of Savoy. Upon the death of her husband Andronikos III Palaiologos in June 1341, Anna became regent on behalf of her son John V, then a child, holding this position for almost six years until February 1347. The Empress’s regency coincided with a long civil war between a legitimist front, supporting the ruling dynasty, and a faction favourable to the former megas domestikos (commander-in-chief), John Cantacuzenus. The severe crisis that affected the political and social structure of the empire – and which represents a major turning point in its late history – also manifested itself on the economic, religious, military and ideological levels: the discourse on the imperial power of Anna of Savoy thus becomes a prism for investigating a historical crossroads of considerable interest, with implications also for Byzantine political thought.
The thesis opens with a historiographical and methodological introduction, followed by three chapters, each devoted to an aspect of the research, followed in turn by an elaborate conclusion. After a critical presentation of the sources (I), the investigation develops along two main axes: on the one hand, the foundations and limits of Anna’s power as a woman and empress (II) and, on the other, the exercise of that power (III).
The second chapter proceeds to a re-examination of Anna of Savoy’s titles in light of the different nuances offered by the official terminology (Augusta, basilis, despoina). Next, the role played by Anna during the reign of her husband Andronikos III (1328-1341) is studied, which made her an essential element of his succession policy, investing all his symbolic and political resources in that. In particular, the period of transition between the end of Andronikos III’s reign and the establishment of the Regency on behalf of his son John V in June 1341 is reconstructed. The chapter concludes with a presentation of contemporary parallels of female regency in the Byzantine broader area (Epirus and Trebizond), as well as the most frequently cited precedent of imperial minority in our sources, namely that of John IV Lascaris, who was removed from power and blinded by Michael VIII in 1261.
The third and longest chapter, on the exercise of power, especially focuses on the creation and promotion of Anna’s imperial image, her entourage and the mechanisms of the exercise of her power, with a particular focus on the repression of internal opposition. These three aspects appear to be linked, in that it was through the monopoly of the spaces in which imperial authority was manifested that Anna of Savoy and her son promoted themselves as the sole holders of legitimacy, and it was the effective and, above all, exclusive use of this legitimacy that determined not only the survival but also the political effectiveness of the regent. A prosopographical analysis of Anna’s entourage has led to the conclusion that the alliances she forged with members of her entourage were based, on the one hand, on the sovereign’s legitimising capacity and, on the other, on her dignitaries’ dependence on this political endorsement. The profiles of the three most influential figures of the Regency, namely the patriarch John Kalekas, the megas doux Alexios Apocaukos and the mesazon John Gabalas, are reconstructed with particular attention.
In the exercise of Anna’s power, a decisive role was played by the repression of dissent, which was effectively exercised against any challenge to the imperial exclusivity of the regent and her son. The first to pay the price was John Cantacuzenus, who was followed by his (real or presumed) supporters, both in the civil and religious spheres. Among them, the most striking case is the deposition of Patriarch John Kalekas in February 1347, which is studied in detail and subjected to a chronological and political reconstruction.
The conclusions return to the concept of late Byzantine imperial mos to contextualise Anna’s attempt to establish herself as the representative of imperial legitimacy: despite the temporary military defeat of 1347, the political structure developed by Anna proved to be solid and resilient, capable of finding effective responses to the many profound crises of her reign.