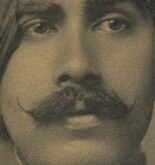Tesi di laurea triennale in Storia, a.a. 2023/2024, relatrice prof.ssa Alice Blythe Raviola
Nel cuore della Milano settecentesca, in un’epoca in cui la scienza era ancora saldamente dominio maschile, una giovane donna, Maria Gaetana Agnesi, si impose come figura centrale del panorama matematico europeo. Il suo trattato Istituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana (1748), benché privo di innovazioni teoriche radicali, fu accolto come un’opera di eccezionale chiarezza didattica e sistematizzazione, diventando rapidamente un testo di riferimento per la formazione sull’analisi matematica in tutta Europa. Scopo di questo lavoro è stato quello di rispondere all’interrogativo di come fosse possibile che una figura simile emergesse da un contesto come il Ducato di Milano che, complice la storiografia ottocentesca e le manzoniane testimonianze, è ritenuto culturalmente periferico. L’indagine ha consentito di ricostruire le condizioni culturali, scientifiche e sociali che resero possibile l’affermazione della Agnesi e, con essa, la nascita di un fertile humus intellettuale nel cuore della Lombardia. La ricerca ha quindi preso le mosse dalla biografia intellettuale della Agnesi, appartenente a una famiglia di mercanti di stoffe e formata da alcuni dei migliori maestri di Milano nel primo Settecento: il teatino Michele Casati, il conte Carlo Belloni, il somasco Francesco Manara e il monaco benedettino Ramiro Rampinelli. Si sono seguite le tracce lasciate da questi matematici e le istituzioni dove operarono, prime fra tutte l’Università di Pavia, l’accademia gesuitica di Brera e le scuole Palatine: un’indagine a ritroso nel tempo, finalizzata a comprendere se e in che modo il tessuto scientifico, tecnico e culturale della Milano tardo seicentesca potesse aver anticipato o addirittura alimentato il rinnovamento del pensiero scientifico settecentesco.
In termini cronologici, si è preferito delimitare ad un arco temporale che si concentrasse sugli ultimi anni di dominio spagnolo sul territorio: dal 1659, anno della Pace dei Pirenei, al 1707, che sancì il passaggio del Ducato di Milano dagli Asburgo di Spagna al ramo d’Austria, dopo la guerra di Successione spagnola. Memori della lezione di Paul Hazard nel suo La crisi della coscienza europea, si è cercato di individuare, sotto la superficie di un’apparente immobilità, i segni di una trasformazione culturale già in atto. La metodologia adottata, di tipo multidisciplinare, ha combinato l’analisi delle fonti a stampa, dei carteggi e delle fonti iconografiche, con un’attenzione particolare agli oggetti e strumenti della scienza come espressioni materiali del sapere rifacendosi alle teorie della Actor-Network Theory di Bruno Latour. Cuore della ricerca è stato l’approfondimento di quattro figure centrali del panorama scientifico milanese seicentesco: Giovanni e Tommaso Ceva, Pietro Paolo Caravaggio senior e il dotto collezionista Manfredo Settala. Le loro attività – che spaziarono dalla matematica teorica all’ingegneria idraulica, fino al collezionismo enciclopedico – sono state analizzate per mettere in luce la profonda interconnessione tra scienza, tecnica e cultura materiale; per leggere inoltre il sistema culturale non solo attraverso i canonici schemi delle produzioni a stampa e delle applicazioni accademiche, ma anche e soprattutto attraverso la scienza che si fa strumento per tradurre forme della pratica, in questo debitori delle teorie di Alexander Koyré.
L’indagine si è articolata lungo tre assi principali: la rete delle relazioni intellettuali attive nel contesto milanese e italiano; le pratiche scientifiche e ingegneristiche come risposte a problemi concreti del territorio; la strumentazione scientifica, analizzata non solo come mezzo tecnico, ma come oggetto di rappresentazione e costruzione del sapere. Il Museo Settala, con la sua collezione di strumenti scientifici e curiosità naturali, è stato assunto come caso emblematico di una scienza enciclopedica in fieri, capace di tradurre lo spirito sperimentale in forma museale.
In conclusione, questa ricerca mostra come il Ducato di Milano, lungi dall’essere una periferia passiva, avesse elaborato, attraverso reti erudite, pratiche applicative e collezioni materiali, una propria visione del sapere, anticipando e contribuendo alla svolta scientifica del Settecento. L’esperienza di Maria Gaetana Agnesi potrebbe così essere letta come l’esordio di un ecosistema intellettuale stratificato e dinamico che avrebbe poi avuto la sua fioritura nel diciottesimo secolo.
Caterina Di Giacomo