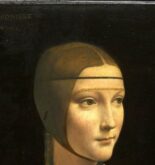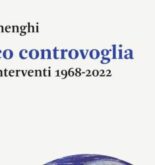In questo semestre dell’a.a. 2024/25 si è svolto il ciclo di incontri “Palai, seminari di storia antica” coordinato dalle professoresse Lucia Cecchet e Laura Mecella. Tutti gli incontri di questo ciclo rientrano nel progetto PRIN 2022 PNRR: “Performing Power: Political Communication, Consensus and Audiences in the Ancient Cities”.
La prima lezione, intitolata “L’oratore e il suo pubblico in Grecia (V e IV sec. a.C.) tra teoria retorica e prassi oratoria” è stata tenuta dalla professoressa Cristina Pepe dell’Università della Campania. In questa lezione, partendo dalla “Retorica” di Aristotele, la professoressa ha illustrato la centralità dell’oratoria nella vita politica ateniese di V e IV secolo. In particolare si è posto l’accento sulla riflessione operata dagli stessi contemporanei (per esempio Tucidide o Demostene) non solo sulle qualità di un buon oratore e sulla struttura e la forma di una buona orazione, ma anche sull’oratoria stessa, arma pericolosa in grado di influenzare le masse. La professoressa ha poi accennato come, durante il periodo ellenistico, l’oratoria pubblica in assemblea diventa prassi meno frequente, mentre si consolida la comunicazione rivolta ai cittadini influenti o al sovrano.
La seconda lezione del ciclo “Speaking truths, half-truths and untruths to power: a formerly enslaved philosopher struggles with his past” è stata tenuta dal professor Christian Thomsen del Museo nazionale danese. Partendo dalle epigrafi rinvenute a Delfi che testimoniano la manomissione degli schiavi, egli ha fatto luce sulla condizione degli schiavi liberati, generalmente poco presenti nelle fonti letterarie. Per approfondire la loro condizione sociale, il possibile stigma di cui erano portatori e, più genericamente, il loro ruolo all’interno della comunità cittadina, il professore si è concentrato sul caso di Bione, filosofo nato in schiavitù ma giunto alla corte di Antigono da uomo libero. Questo studio ha permesso anche di indagare la condizione degli schiavi stranieri, anche non greci, e il processo di integrazione in seguito alla loro liberazione.
Il ciclo è proseguito con la lezione del dott. Andrea Pierozzi “Enargheia: displaying facts ‘before the eyes’ of the audience in classical oratory and historiography”, nel corso della quale egli ha esposto le tecniche attraverso le quali gli oratori e gli storici dell’Atene classica permettevano all’uditorio di visualizzare gli eventi raccontati. Centrale è il concetto di “enargheia” (ἐνάργεια, lett. “chiarezza”), cioè la capacità del narratore di sollecitare i sensi dei presenti con la forza delle sue parole. Questo permetteva, nel caso di un processo, di rendere i giudici in un certo senso “testimoni oculari” dei fatti o, nel caso del racconto storico, di assistere “in prima persona” agli eventi. In quest’ultimo caso è notevole l’esempio di Tucidide e la sua cura nel raccontare episodi di violenza di massa con estrema vividezza. Per l’oratoria è stato presentato il caso di studio di Demostene che descrive l’orrore delle devastazioni della guerra per rafforzare la sua posizione nel dibattito contro Eschine. In chiusura si è accennato all’utilizzo dell’”enargheia” anche nelle epigrafi.
La penultima lezione è stata tenuta dal professor Jakub Filonik, dell’Università della Slesia, intitolata “Orators, segretaries and technical communication in athenians courts”. Dopo un’introduzione in cui il professore ha brevemente ricostruito la procedura giudiziaria ateniese, la lezione si è concentrata sul ruolo dei segretari e dei sottosegretari attraverso un’analisi delle fonti archeologiche e letterarie. Questi si occupavano di redigere, conservare e presentare davanti ai giudici gli atti processuali. Nel corso della lezione il professore ha toccato tutti gli aspetti pratici della conduzione di un processo nell’Atene di IV secolo, con un’attenzione particolare alla conservazione dei documenti e al loro ruolo nell’oraratoria giudiziaria.
Chiude il ciclo la lezione della professoressa Irene Salvo, dell’Università di Verona, che ha tenuto una conferenza dal titolo “Communication strategies and power dynamics in the healing inscriptions from Epidaurus”. La professoressa, partendo dalle iscrizioni del tempio di Asclepio ad Epidauro, ha ricostruito il funzionamento del santuario e ha esposto le tecniche impiegate dai sacerdoti per presentare l’azione del dio. Ha utilizzato un approccio molto affascinante basato sulle scienze cognitive, al fine di indagare i riti e i rituali compiuti nel tempio e il modo in cui questi potevano essere percepiti dai pellegrini. In particolare ha presentato tre casi di studio, basati su tre epigrafi votive, che illustrano i poteri del dio, ma che attestano anche la presenza di scetticismo tra la popolazione. La professoressa ha poi analizzato il ruolo delle epigrafi votive nella comunicazione tra sacerdoti e fedeli, mostrando come fossero utilizzate per controllare le dinamiche di potere interne al santuario.
Il ciclo è stato un’occasione per riflettere sul ruolo preminente occupato dalla comunicazione nella polis di età classica e post-classica e su come essa fosse fondamentale per garantire il consenso. Inoltre i vari interventi hanno messo in luce il ruolo dell’uditorio, che già i contemporanei ritenevano centrale nel determinare le tecniche comunicative adottate dagli oratori.
Andrea Bonini