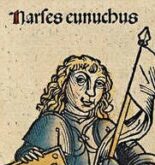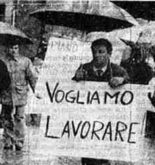L’esperienza coloniale italiana è durata circa sessant’anni e ha coinvolto principalmente i territori africani. Pur non raggiungendo mai i livelli di espansione geografica di altre potenze europee, l’intervento italiano in quei territori ha avuto comunque una rilevanza all’interno del generale fenomeno del colonialismo ed è stato una parte significativa del processo di costruzione nazionale.
La tesi parte da una domanda: come mai di quel capitolo così importante della storia nazionale, la cui ultima guerra, quella fascista in Etiopia, ha visto la partecipazione di quasi mezzo milione di uomini, si parla così poco? Tutta la retorica e la propaganda, che per più di mezzo secolo hanno accompagnato gli italiani alla conquista dell’Africa, scompaiono dal discorso pubblico alla fine del secondo conflitto mondiale. La perdita di queste ultime, secondo il dettato del trattato di pace del 1947, permise agli italiani di non affrontare le proprie responsabilità in quei territori. Quando il passo della decolonizzazione africana accelerò negli anni Sessanta, il confronto con una realtà di sopraffazione e violenza sembrò così essere una questione che riguardava altri. Il silenzio colpì anche il mondo accademico, che per molti anni ignorò questo campo di studi o lo descrisse con impostazioni apologetiche e da una prospettiva sostanzialmente coloniale.
È solo a partire dalla metà degli anni Sessanta, grazie a studiosi quali Roberto Battaglia, Giorgio Rochat, Angelo Del Boca, che appaiono le prime vere opere di sintesi sul colonialismo italiano con un’impostazione di ricerca distante dai toni celebrativi dell’italiano portatore di civiltà. In questo nuovo approccio, Angelo Del Boca ha un ruolo di particolare rilievo, diventando un punto di riferimento, in Italia e all’estero, per competenza, vastità e accuratezza di ricerca. Le sue opere principali, Gli italiani in Africa orientale e Gli italiani in Libia, edite da Laterza in 6 volumi tra il 1976 e il 1986, diventano il vero e proprio punto di partenza per ogni studio sulle colonie italiane. Convinto come era che l’elaborazione di un passato di sopraffazione non potesse rimanere circoscritto ad una parentesi ormai lontana, Del Boca si impegnò costantemente nella promozione di un dibattito pubblico sulle questioni coloniali. Sono rimaste celeberrime le sue discussioni con Indro Montanelli sull’uso dei gas in Etiopia, gli articoli su quotidiani e riviste e l’impegno come autore e direttore di riviste storiche. “Studi piacentini” prima e “I sentieri della ricerca” poi hanno contribuito ad avviare la “decolonizzazione” degli studi. Nicola Labanca, Alessandro Triulzi, Gianpaolo Calchi Novati, Marco Lenci e più recentemente Valeria Deplano, Alessandro Pes, Antonio Morone, Emanuele Ertola, sono solo alcuni tra gli autori che negli ultimi trent’anni hanno reso possibile l’enorme balzo degli studi coloniali in Italia. Merito anche di un nuovo approccio legato ai post-colonial studies, gli storici italiani hanno saputo colmare quel ritardo di analisi da sempre imputato al settore, indagandone molti aspetti. I campi di studio ormai sono moltissimi e si aprono a svariate discipline, allargando le prospettive e le collaborazioni, permettendo la comprensione di un fenomeno che è allo stesso tempo particolare e universale e che lungi dall’essere soltanto politico ed economico, ha plasmato e plasma la vita, il modo di pensare e di percepire il reale di milioni di persone nel mondo. Questa nuova stagione di studi ha consentito di inserire finalmente anche il colonialismo italiano all’interno del fenomeno più ampio del colonialismo europeo e di considerarlo non più come minore, più buono o straccione ma un reale, tangibile e provato episodio di sopraffazione e violenze che di inferiore ha avuto solo l’ampiezza cronologica e geografica.
Nell’ultima parte, la tesi cerca di raccontare come la cultura colonialista e imperialista abbia avuto ampia influenza sulla società italiana, modellando pensieri, linguaggi, immaginari e invadendo gli spazi urbani. Evidenzia, inoltre, come l’avanzamento delle ricerche sia filtrato poco nel discorso pubblico. I settori indagati sono tre. Il primo è la scuola, luogo di passaggio per tutti e centro di formazione dello sguardo verso noi stessi e il mondo. Alcuni articoli e la consultazione dei manuali scolastici dagli anni Cinquanta in poi dimostrano come al colonialismo italiano sia stata data un’attenzione sempre minore sia in termini di spazio che in termini di rilevanza. Pur notando come l’accuratezza delle informazioni è andata aggiornandosi in parallelo alla ricerca accademica, quello che manca è lo spazio fisico nei manuali, dove ad oggi le righe riservate a questa tematica non arrivano oltre l’1%. La mancata elaborazione delle nostre responsabilità riflessa nei manuali scolastici influenza le nuove generazioni e la loro visione dell’Africa, degli africani e del nostro intervento in quelle regioni.
Il secondo settore sono le persistenze coloniali nelle nostre città. Sono ancora moltissimi i monumenti e le vie che parlano di colonialismo e lo fanno con il tono celebrativo che era stato loro assegnato nel momento fondativo. È questo forse l’ambito in cui l’importanza del colonialismo come strumento di costruzione dell’identità nazionale già in età liberale rivela la sua importanza. Una volta fatta l’Italia, cominciò a diffondersi anche l’idea che il vero patriottismo passasse attraverso la potenza militare e l’espansione coloniale: l’avventura africana sembrava essere così l’occasione perfetta. Monumenti e odonomastica raccontano una parte della nostra storia, del processo di negoziazione della memoria tra potere e società come parte di un equilibrio che varia nel tempo tra oblio e ricordo, del nostro modo di percepire noi stessi sia allora che oggi. Siamo così orgogliosi di avere una via dell’Amba Aradam che costantemente ricorda una battaglia in cui abbiamo sconfitto un esercito che combatteva per la sua indipendenza?
Infine, si accenna alla presenza del discorso coloniale nei media e nella cultura generale, nella letteratura e nel cinema. Lungi dall’essere sparito nell’immediato dopoguerra, esso ha assunto sfumature diverse a seconda degli scopi istituzionali, diminuendo costantemente la sua presenza ma aiutando, sin da subito, il consolidamento del mito degli italiani “brava gente”. Un mito che sembra informare ancora oggi la nostra autonarrazione e che ha abbracciato e nascosto tutta quella cultura militarista e nazionalista che è stata parte integrante della storia nazionale nella prima metà del Novecento.
Angelo Del Boca ha sempre auspicato un dibattito serio intorno al colonialismo italiano, alle responsabilità e alle violenze ad esso collegate. Un dibattito necessario non tanto per distribuire colpe, ma per avviare una presa di coscienza collettiva del ruolo italiano all’interno di un fenomeno così vasto e ramificato nella storia mondiale, che non ha mai smesso di influenzare il nostro presente.